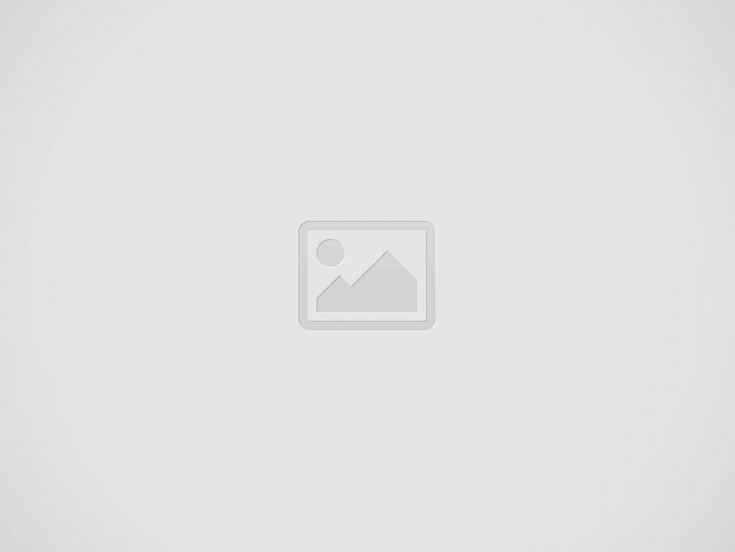di Giovanna Ferrara, Presidente Unimpresa
I primi due mesi della presidenza Trump sono stati una turbina imprevedibile, simili al Re Lear di Shakespeare che sfida la tempesta senza controllo, con nessuno in grado di riportare ordine. Quattro sono le direttrici che hanno caratterizzato la sua azione di governo: le politiche commerciali, il ridimensionamento del governo federale, la gestione della crisi russo-ucraina e un’espansione dell’esecutivo che travalica i confini del potere legislativo e giudiziario. Quest’ultimo aspetto, pur contribuendo a un clima di incertezza generale, non rientra direttamente nel nostro esercizio previsionale. Sul fronte della crisi russo-ucraina, l’amministrazione americana ha adottato una sorprendente accondiscendenza verso le richieste russe, andando oltre le aspettative iniziali.
Sebbene questo non abbia ancora portato a un cessate il fuoco stabile, si è rafforzata l’idea che un riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia possa, nel tempo, incrementare l’offerta globale di idrocarburi, con possibili benefici per i mercati energetici. I tagli al governo federale, però, sono stati implementati senza una strategia chiara, spesso superando i limiti dei poteri dell’esecutivo. Questi interventi hanno generato risparmi di spesa difficili da quantificare: i resoconti del DOGE si sono rivelati prima inaffidabili e poi sono stati oscurati, impedendo verifiche indipendenti. Ne deriva un’incertezza palpabile per i dipendenti pubblici, gli enti e le imprese che collaborano con il governo, con effetti destabilizzanti. La nostra analisi suggerisce che i benefici di queste misure saranno limitati, soprattutto se confrontati con l’impatto negativo dell’estensione degli sgravi fiscali. Anche nell’ipotesi in cui il Congresso approvasse tag significativi a programmi sanitari come Medicare e Medicaid per l’anno fiscale 2026, il deficit federale difficilmente scenderebbe sotto la soglia dei 6.500 miliardi di dollari. Si delinea così una politica fiscale espansiva ma poco efficace nel sostenere la domanda aggregata, a causa di un mix di misure scarsamente equilibrato.
Nel campo delle politiche commerciali, l’approccio di Trump ha ribaltato ogni previsione. A dicembre, si ipotizzava un aumento delle barriere tariffarie mirate e differenziate: niente dazi su Messico e Canada, incrementi moderati verso l’Unione Europea – in cambio di impegni su armamenti e combustibili fossili – e una stretta decisa contro la Cina, con controlli rigorosi sull’aggiramento delle tariffe. Queste previsioni si basavano sull’assunto, poi rivelatosi errato, che le scelte erano guidate dalla razionalità economica e dalla priorità strategica di isolare la Cina, mantenendo saldi i rapporti con gli alleati storici. Sconvolgere le catene di approvvigionamento nordamericane sembrava privo di senso in tale logica. Invece, questi due mesi messi in luce hanno due dinamiche inattese.
Primo, Trump vede i dazi come una soluzione universale per problemi disparati – dal deficit federale al rilancio delle industrie tradizionali, fino al riequilibrio commerciale – e ritiene di averli usati troppo timidamente nel primo mandato, frenato da un team disunito e dalle resistenze del Congresso. Ora, con un legislativo allineato e un’amministrazione priva di voci contrarie, l’attuazione è rapida e radicale.
Secondo, emerge un’anima mercantilista che considera le politiche commerciali parte di una strategia egemonica, svincolata dalle alleanze tradizionali. Negli ultimi ottanta anni, uno squilibrio commerciale con i paesi alleati era tollerato, compensato dall’accettazione del dollaro come valuta di riserva e dalla garanzia di sicurezza nelle catene di fornitura in caso di conflitti.
Oggi, i dazi generalizzati riflettono una visione imperialistica che collega avanzo commerciale a potenza geopolitica, trattando gli ex alleati come vassalli – sul modello dell’Unione Sovietica con il Patto di Varsavia o degli USA in America Latina tra gli anni ’50 e ’70. In questa logica, colpire Canada e Messico, economicamente integrati e dipendenti dagli Stati Uniti, serve a piegarli più facilmente, estorcendo concessioni come rivalutazioni valutarie, acquisti di produzione americana o emissioni di debito pubblico statunitense. Si ipotizza persino un uso delle leve politico-militari per riconciliare dazi, deprezzamento del dollaro e centralità del sistema finanziario americano, come suggerito dal presidente del Council of Economic Advisers, Stephen Miran. Tuttavia, l’incertezza su obiettivi e metodi ha già indebolito la fiducia nel dollaro, rafforzatosi dopo la vittoria di Trump ma poi in calo con l’avvio delle politiche, alimentando timori di recessione.
Tre problemi principali emergono da questa linea. In primo luogo, i dazi su larga scala aumentano l’aumento e rallentano la crescita: il PIIE stima un +1% sull’acquisto nel 2025 solo per i dazi su Messico, Canada e Cina, con segnali di pressioni sui prezzi già visibili nelle imprese manifatturiere. Le aspettative di crescita delle famiglie crescono, rischiando uno shock persistente che tradirebbe la promessa di maggior potere d’acquisto. Secondo, l’attuazione caotica – annunci, modifiche, sospensioni repentine – genera incertezza, frenando investimenti, assunzioni e mercati finanziari.
Trump sembra indifferente a queste reazioni, presentando i costi come necessari per un futuro prospero, anche se emergono primi segnali di preoccupazione nell’esecutivo. Terzo, la teoria che i paesi colpiti cedano alle pressioni si scontra con resistenze, come in Canada, e con la sfiducia generata dall’attacco a partner dell’USMCA, firmata dallo stesso Trump nel 2020. Ciò potrebbe isolare gli USA, indebolire il dollaro e complicare il contenimento della Cina. Un cambio di rotta potrebbe arrivare ad aprile o con un calo di consenso verso le elezioni di midterm del 2026. Prevediamo dazi medi al 20% sull’UE (poi 10% nel 2026), 30% sulla Cina, con un PIL USA al 1,7% e inflazione al 2,8%, evitando recessione nel breve termine. Se dazi persistessero, la crescita globale scenderebbe (-0,4% nel 2026-27), con la caduta degli USA in risalita e rischi finanziari crescenti, potenzialmente aggravati da una crisi di fiducia sui mercati.